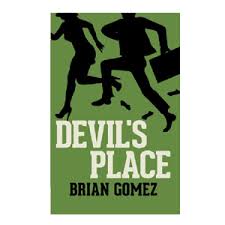Strana Malesia. Una fiera intitolata Sexsualiti merdeka, i reading in lingua inglese. Una letteratura malay ambigua, ma da esplorare. E questo l’ho fatto.
Strana Malesia. Una fiera intitolata Sexsualiti merdeka, i reading in lingua inglese. Una letteratura malay ambigua, ma da esplorare. E questo l’ho fatto.
Ho incontrato Faisal Teherani. Con una posa da chierichetto mi aveva offerto la sua erudizione, la sua visione filosofica. Infilò il suo dio da tutte le parti, in qualsiasi possibile anfratto del discorso.
Pensavo fosse un vezzo, davanti all’editore europeo. Poi mi ero letto parte dei suoi romanzi tradotti in inglese: sempre dio mai dimenticato, nominato almeno una volta a pagina, quasi fosse l’io narcisistico di un cattivo showman italiano alle prese con la propria autobiografia. Il driver, si direbbe in inglese, del racconto cattivo, quello che fa male agli eserciti dei lettori.
Non c’è solo Faisal Teherani. Incontrai un degnissimo Samad Said dalla lunga e sottile barba bianca – come l’Albus Silente di Harry Potter, mi ha disse lui, aggiungendo: li ho letti tutti, mi piace moltissimo.
Mi spiegò la necessità dello scrittore malay: fare un suo slalom tra le pieghe della censura. E poi lessi i suoi romanzi, e c’era molto di più che in Faisal Teherani, scrittura, poesia. Ma sempre questo dio onnipresente, ingombrante, che non la smette di tirar per la giacchetta il lettore.
–
A Singapore, davanti a una tazza di tè, ho incontrato un giorno Isa Kamari. Scrittore di lingua malese e, dovrei aggiungere, di razza malese, di cultura malese, e musulmano come molti malesi, almeno quelli di una certa età. Dei suoi otto romanzi, alcuni sono stati tradotti in inglese. Due di questi, curiosamente, hanno lo stesso soggetto: l’adozione di una bambina da parte di una famiglia malese e musulmana. Una bambina olandese, in Nadra. E una bambina cinese in One Earth, che il mio amico Fong Hoe Fang ha pubblicato con Ethos Books.
Il post continua qui »
Commenta